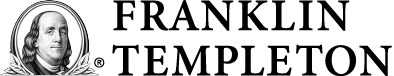CONTRIBUTORI

Shane Hurst
Managing Director, Portfolio Manager
Elementi chiave da ricordare
- Le infrastrutture hanno un ruolo chiave nel passaggio alla decarbonizzazione e allo zero netto, offrendo sia opportunità che sfide a seconda dei diversi settori.
- In quest’articolo tracciamo i prossimi passi per i settori delle infrastrutture, evidenziando un’accelerazione degli investimenti nei servizi per l’erogazione di elettricità, un cambiamento di mentalità nel settore ferroviario, transizioni nelle infrastrutture energetiche e la sfida delle emissioni Scope 3 per gli aeroporti.
- Le infrastrutture quotate nelle borse globali consentono agli investitori di accedere a un investimento in via di accelerazione tramite asset liquidi di ottima qualità e geograficamente diversificati.
Che cosa si intende per zero netto, e perché è importante?
Per zero netto si intende il saldo tra la quantità del gas serra (GHG) prodotto e la quantità rimossa dall’atmosfera. Si arriva allo zero netto quando la quantità che aggiungiamo non supera quella che eliminiamo. Con l’Accordo di Parigi, i paesi si erano accordati per limitare il riscaldamento a decisamente meno di 2° Celsius, ponendosi come obiettivo ideale un limite di 1,5° Celsius. Gli impatti sul clima che si stanno già verificando in tutto il mondo, anche con un riscaldamento solo di 1,1° Celsius: dallo scioglimento dei ghiacci a ondate di calore devastanti e tempeste più violente, dimostrano l’urgenza di ridurre al minimo gli aumenti di temperatura.
Le ultime scoperte scientifiche suggeriscono che per realizzare gli obiettivi della temperatura previsti dall’Accordo di Parigi sarà necessario raggiungere lo zero netto per le emissioni in tempi che possono variare in funzione dello scenario per ogni singolo grado (Figura 1). Il requisito minimo assoluto è che gli emittenti maggiori (ad esempio Stati Uniti, Unione Europea e Cina) dovrebbero raggiungere lo zero netto per le emissioni di GHG entro il 2050, e idealmente molto prima, dato il ruolo straordinario di queste economie nel determinare la traiettoria delle emissioni globali.
Figura 1: Tempistica globale per arrivare allo zero netto delle emissioni
Fonte: World Resources Institute, IPCC.
Il settore dell’energia è responsabile per circa l’80% delle emissioni di CO2 prodotte dall’uomo (secondo l’International Renewable Energy Agency, o IRENA) e ha un ruolo centrale nel realizzare la decarbonizzazione necessaria per raggiungere lo zero netto entro il 2050.
La parte più importante nella transizione dell’energia globale è la combinazione dell’uso crescente di tecnologie per energie rinnovabili a basso costo e la diffusione dell’elettricità per i trasporti e il riscaldamento. L’elettrificazione consente di sostituire i combustibili fossili con l’elettricità, che non rilascia carbonio e migliora notevolmente l’efficienza generale della fornitura di servizi associati all’energia. Le vetture elettriche, ad esempio, sono più efficienti di quelle con motori a combustione interna. Anche la generazione di energia idroelettrica è più efficiente di quella generata dal gas naturale. È un elemento importante, considerando la necessità di accelerare le riduzioni di intensità dell’energia.
Le infrastrutture hanno un ruolo chiave nel passaggio alla decarbonizzazione e allo zero netto. In questo documento, esaminiamo il modo in cui settori diversi delle infrastrutture si sono gradualmente spostati a favore dell’obiettivo dello zero netto, e quale dovrebbe essere il prossimo passo.
Caso 1: Servizi di erogazione dell’elettricità
I servizi di erogazione dell’elettricità si possono classificare generalmente in tre sottosettori: generazione (GenCo, da generation companies), reti di trasmissione e distribuzione (T&D) e forniture retail. I più rilevanti per il passaggio allo zero netto sono GenCo e T&D.
Servizi di pubblica utilità: Quadro generale
GenCo: Nell’ultimo decennio, trainati da politiche favorevoli (ad esempio tariffe agevolate, crediti d’imposta e portafogli standard di energie rinnovabili) gli investimenti delle GenCo sono stati sempre più orientati all’aumento della capacità di energie rinnovabili.
Fino al 2010, l’aumento della capacità di energie rinnovabili globali era inferiore a 100 GW/anno, ma nel 2019 il ritmo era raddoppiato fino a raggiungere quasi 200 GW/anno, con in testa i servizi di pubblica utilità e accompagnato dalle società erogatrici di energia. Allo stesso tempo, i servizi di pubblica utilità hanno abbandonato impianti per la produzione di energia termica e nucleare. La variazione del mix di generazione e capacità di queste società è stata la forza sulla quale si sono imperniate le loro riduzioni di emissioni di GHG.
Prendiamo per esempio il maggiore emittente di GHG, la Cina; nell’ultimo decennio le capacità di energia eolica e solare delle GenCo di proprietà statale più importanti sono aumentate a un tasso molto superiore a quello degli impianti alimentati a carbone, ottemperando alla direttiva più rigida del governo centrale per una riduzione dell’affidamento sul carbone e delle emissioni di GHG. Inoltre sono state sostituite le unità di dimensioni modeste (<300 MW) con altre più ampie e più efficienti, promuovendo quando possibile una cogenerazione di energia termica combinata (CHP) per gli impianti di energia termica, ristrutturando le unità alimentate a carbone per ridurre i consumi unitari di carbone e partecipando alla ricerca e agli studi nazionali per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio (CCUS) e il trading del carbonio. Di conseguenza, la quota della generazione di energia alimentata a carbone è scesa dal 67% della capacità totale nel 2010 al 49% nel 2020. Nel 2020, la Cina rappresenta già il volume maggiore in assoluto della capacità globale di energia eolica e solare in termini di aggiunta annuale e flotte cumulative.
T&D I player della trasmissione e distribuzione in tutto il mondo hanno aumentato gli investimenti nello stoccaggio, la digitalizzazione, la gestione flessibile della domanda e l’installazione di contatori smart per risolvere problemi di stabilità e flessibilità presentati dall’uso crescente di energie rinnovabili. Questi investimenti sono i propulsori di riduzioni delle emissioni indirette, mentre la riduzione dell’emissione diretta (Scope 1) si realizza principalmente abbassando le perdite di esafluoruro di zolfo (SF6). Secondo i dati di IRENA, l’energia solare ed eolica in quanto energia rinnovabile variabile ha rappresentato il 10% della generazione globale di elettricità totale nel 2019, rispetto al 5% del 2015. Prendendo ancora una volta come esempio la Cina, le reti elettriche hanno investito notevolmente per migliorare l’affidabilità e ridurre i tagli dei parchi eolici e solari (riduzione deliberata di produzione a meno di quanto sarebbe stato prodotto per equilibrare la fornitura di energia). Hanno anche investito in linee di trasmissione a voltaggio ultra alto per collegare le province occidentali, dove abbondano le risorse di energia rinnovabile, e le province orientali, dove vi è una forte domanda di energia.
Servizi di pubblica utilità: Prossimi passi
Prevediamo che questi trend delle società erogatrici di energia elettrica continueranno ad accelerare fino al 2050.
L’elettricità è destinata a diventare il fornitore principale di energia per i consumi entro il 2050, rappresentando circa il 51% dei consumi, in aumento rispetto al 21% del 2018 e al 30% previsto per il 2030, secondo IRENA. Energie rinnovabili, elettrificazione ed efficienza energetica sono i principali pilastri di questa transizione. Entro il 2050, per realizzare un obiettivo di 1,5° Celsius, la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili potrebbe arrivare al 90%, rispetto al 25% odierno.
Le reti di trasmissione si stanno evolvendo per far fronte con maggiore flessibilità alla quota crescente di energia rinnovabile variabile. Inoltre, l’aumento di nuove fonti di domanda, quali l’adozione delle vetture elettriche e delle pompe di calore, comporterebbe maggiori investimenti in reti di distribuzione e misure flessibili quali lo stoccaggio.
Affinché le GenCo e le società di T&D possano soddisfare questa domanda di elettricità, IRENA prevede investimenti complessivi per 130 trilioni di dollari tra il 2021 e il 2050, con una media di 4,4 trilioni di dollari all’anno, di cui il 26% per energie rinnovabili e il 22% per elettrificazione e infrastrutture. È un’accelerazione notevole (Figura 2).
Figura 2: La transizione energetica richiede investimenti notevoli
Fonte: IRENA World Energy Transitions Outlook 2021.
Con il settore per la generazione di energia statunitense che produce il 31% delle emissioni di CO2 correlate all’energia del paese, i servizi di pubblica utilità restano al centro del dibattito in merito allo zero netto quali principali operatori per la generazione di energia con emissioni di carbonio. Tuttavia dalla firma dell’Accordo di Parigi nel 2016 in poi le politiche ambientali nel settore sono diventate molto più importanti. Per quasi tutte le società vi sono obiettivi di emissioni nelle rispettive giurisdizioni e per il mercato si è prevista un’inversione strategica dalla generazione di energia da combustibili fossili a energie rinnovabili. Di conseguenza, si prevede una crescita notevole delle energie rinnovabili, a spese del carbone e della generazione alimentata a gas.
Figura 3: La transizione energetica richiede investimenti notevoli
Fonte: Expected Changes in U.S. Power Generation Mix.
Servizi di pubblica utilità: sfide e rischi
Considerando il progresso tecnologico per la generazione di energia eolica e solare e il conseguente abbassamento delle barriere all’accesso nonché dei costi unitari upfront, molte società, tra cui produttori di attrezzature, grandi società petrolifere e istituzioni finanziarie, sono in competizione più attiva con i servizi di pubblica utilità. Gli spread del rendimento sul costo del capitale potrebbero anche diventare meno redditizi rispetto agli anni precedenti. Il sostegno dei sussidi potrebbe cessare dopo i primi 10-15 anni, lasciando le società esposte a rischi di prezzi commerciali o rendimenti più bassi. Tuttavia, l’importanza dei meccanismi di sostegno tramite l’erogazione di sussidi potrebbe diminuire a seguito di un rapido calo del costo livellato dell’energia. I servizi di pubblica utilità potrebbero comunque optare per contratti (ad esempio tramite accordi basati sul potere di acquisto delle società) per mitigare i rischi associati alla volatilità del prezzo dell’energia. Per nuove tecnologie quali l’energia eolica offshore, la preparazione dei progetti e la costruzione richiedono tempi molto più lunghi, poiché possono essere più suscettibili a ritardi nella costruzione e nella concessione di permessi; considerando i tempi lunghi per l’avviamento, potrebbe aumentare anche l’incertezza relativa a un superamento dei costi e la capacità di trasferirli sui clienti.
D’altra parte, gli investimenti nelle reti avvengono abitualmente in base a revisioni pluriannuali dei regolamenti o tariffe, per cui il rendimento realizzato e il profilo di cash flow sono relativamente prevedibili. Un punto che richiede prudenza è l’accessibilità dei clienti, specificamente qualora l’aumento di capex si rifletta nella bolletta finale, considerando che i regolamentatori di gas ed elettricità (ad esempio Ofgem nel Regno Unito) devono riuscire nel difficile compito di bilanciare la pressione sociale e le necessità dei clienti con rendimenti soddisfacenti per gli operatori di sistema. Ciò nonostante, i rischi per la trasmissione e distribuzione generalmente sono modesti; ad esempio, in Italia i costi di trasmissione rappresentano meno del 5% delle bollette elettriche per gli utenti finali.
Negli Stati Uniti, come abbiamo visto quest’inverno nel Texas, la sfida chiave per i servizi pubblici quando le energie rinnovabili aumentano notevolmente consiste nel mantenere una rete stabile mentre la generazione di base è sostituita da risorse intermittenti.
Caso 2: Ferrovie
Il settore ferroviario del Nord America ha un ruolo essenziale nei servizi per il trasporto merci. Per i trasporti a lunga distanza, la ferrovia è la forma di trasporto meno costosa e più efficiente in termini di carburanti, ed è un partner importante nell’attività del settore industriale. Le spedizioni ferroviarie principali comprendono prodotti agricoli e forestali, materiali per costruzioni, componenti auto, carbone e prodotti chimici.
Ferrovie: Quadro generale
Le linee ferroviarie sono tra i vincenti finali per considerazioni ESG nel settore dei trasporti per la loro abilità esclusiva nel ridurre le emissioni di GHG correlate ai trasporti. Le ferrovie hanno un’efficienza media 4 volte superiore in termini di consumo di carburanti rispetto ai camion, con emissioni di GHG inferiori fino al 75%. Con questi benefici ambientali, il settore è considerato favorevolmente da un punto di vista regolamentare, e i clienti sono sempre più disposti a passare dai trasporti con camion a quelli ferroviari per ridurre la loro impronta di carbonio.
Fino a poco tempo fa, le linee ferroviarie hanno stabilito benchmark di miglioramento conservatori, che prevedevano una riduzione media tra il 5% e l’8% delle emissioni di GHG nel tempo. Questi obiettivi sono stati raggiunti facilmente, e oggi la ferrovia è concentrata al massimo nel migliorare l’affidabilità dei servizi e diventare un’alternativa fattibile ai camion per distanze più brevi (Figura 4). La ferrovia sta raccogliendo i benefici di miglioramenti dei servizi che consentono una conversione modale graduale dai camion ai treni (Figura 5).
Figura 4: Un treno copre distanze maggiori per unità di combustibile
Fonte: Wolfe Research.
Figura 5: Efficienza di combustibile dei treni rispetto ai camion
Fonte: Association of American Railroads, U.S. Energy Information Administration.
Ferrovie: Prossimi passi
Riflettendo un forte cambiamento di mentalità nel settore, negli ultimi due anni le ferrovie hanno iniziato a impegnarsi nell’iniziativa CDP Science-Based Targets (SBT), che stabilisce indipendentemente obiettivi di riduzione delle emissioni societarie allineate a ciò che gli scienziati del clima ritengono necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Le ferrovie che hanno pubblicato gli obiettivi mirano a una riduzione media del 30% delle emissioni di GHG entro il 2030.
Mentre in ultima analisi il trasporto ferroviario deve bruciare diesel per alimentare le locomotive, negli ultimi anni l’efficienza è drasticamente aumentata.1 Con l’adozione a livello generale del Precision Scheduled Railroading (PSR), le ferrovie bruciano attualmente meno combustibile che mai per t/miglio e hanno tagliato notevolmente le emissioni di GHG. Ciò non è più benefico solo per l’ambiente, bensì giova anche alla loro bottom line.
Ferrovie: sfide e rischi
La sfida principale affinché le ferrovie realizzino i propri obiettivi ESG è probabilmente il loro organismo di regolamentazione, il Surface Transportation Board (STB), che ha analizzato i reclami degli speditori secondo cui il PSR provocava problemi indesiderati pur aumentando l’efficienza dei combustibili. L’STB appare tuttavia sempre più favorevole al PSR.
Ulteriori miglioramenti si basano anche sulle società ferroviarie che continuano a sviluppare la propria tecnologia con ottimizzatori dei viaggi e locomotive alimentate a gas naturale (vs. diesel). Gli sviluppi tecnologici presumibilmente richiederanno tempo, per cui gli obiettivi di riduzione dei GHG saranno a rischio qualora le ferrovie non possano continuare a sviluppare e impiegare efficientemente queste tecnologie.
Caso 3: Infrastrutture per l’energia
Le infrastrutture per l'energia consistono principalmente di grandi condutture per petrolio e gas che trasportano le materie prime attraverso campi di petrolio e gas fino ai vari mercati dai quali proviene la domanda. I servizi di pubblica utilità per la distribuzione del gas fanno parte anch’essi della catena di valore che porta il gas dai grandi gasdotti convogliandolo nelle proprie reti fino a raggiungere il cliente finale.
Infrastrutture per l’energia: Quadro generale
Il settore dei gasdotti ha fornito un forte contributo alla riduzione delle emissioni di GHG nel settore dell’elettricità, dovuto in ampia misura al fatto che il gas genera circa metà delle emissioni di CO2 rispetto al carbone, e l’ha gradualmente sostituito come combustibile per la generazione di elettricità.
Recentemente questa tendenza è rallentata notevolmente, poiché il prezzo dell’energia rinnovabile si è avvicinato alla parità con i combustibili fossili, aiutato dall’aumento degli impegni e dei sussidi governativi per il passaggio a un’energia più pulita. Negli ultimi anni ciò ha portato il gas a diventare un obiettivo per la riduzione delle emissioni di GHG piuttosto che una soluzione, come nei decenni precedenti. In aggiunta, l’evoluzione dell’elettrificazione dei trasporti tramite vetture elettriche attualmente minaccia il futuro del petrolio e l’esistenza degli oleodotti.
Infrastrutture per l’energia: sfide e rischi
Mentre aumentano gli impegni nel raggiungimento dello zero netto, i settori del petrolio e gas affrontano sfide maggiori rispetto ad altri settori di infrastrutture, con le business line principali che fanno parte della catena di valore degli emittenti di GHG. Eppure le società di pipeline stanno ancora cercando di contribuire al passaggio allo zero netto, e molte di loro l’adottano come opportunità di crescita.
Le sfide principali per le società di infrastrutture per l’energia consistono nella rivoluzione per le attività di petrolio e gas tradizionali e le nuove tecnologie e investimenti in energia pulita. Con la maggior parte dei cash flow generati da mezzi tradizionali nell’ultimo decennio, il rischio di esecuzione consisterà nella loro incapacità di commercializzare nuove attività o non riuscire a competere efficacemente con nuovi player. Mentre siamo ottimisti riguardo al raggiungimento dello zero netto, restiamo scettici sui benefici della transizione per le società di pipeline, a parte il retrofitting della rete per gestire gas naturale e idrogeno rinnovabili.
Le pipeline del Nord America colgono opportunità green
Molte società di pipeline del Nord America stanno cogliendo l’opportunità per passare a un futuro più verde. Ad esempio, Williams Companies, proprietaria di pipeline adibite principalmente a gasdotti, ha pianificato il raggiungimento dello zero netto con progetti che fanno leva sulle proprie reti già esistenti, inclusa la miscelazione con l’idrogeno e interconnessioni con gas rinnovabili.
Caso 4: Aeroporti
I viaggi aerei sono notevolmente aumentati a partire dagli anni Sessanta, considerando il calo dei prezzi reali dei biglietti e le maggiori disponibilità finanziarie personali. Oggi i viaggi aerei rappresentano circa il 2,5% delle emissioni globali di CO2 e il 12% delle emissioni dei trasporti, con emissioni per chilometro di viaggio relativamente elevate, che risultano in tendenze quali il “flight shaming”, ossia l’atteggiamento critico nei confronti dei viaggi aerei. Di conseguenza, in questo periodo è fortemente cresciuto anche il traffico negli aeroporti.
Aeroporti: Quadro generale
Abitualmente, le emissioni degli aeroporti sono basse rispetto a quelle correlate ai viaggi degli aerei e dei trasporti per i collegamenti con gli aeroporti via terra (Figura 6). La fonte principale delle emissioni dirette di GHG degli aeroporti è il consumo di elettricità. Storicamente, gli sforzi per ridurre l’emissione di GHG degli aeroporti si sono concentrati sull’efficienza energetica, ad esempio con l’installazione di illuminazione a LED e migliorando l’efficienza dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), nonché irrobustendo caratteristiche termiche e di illuminazione.
Figura 6: Fonti di emissioni negli aeroporti
Fonte: Airport Carbon Accreditation.
Gli aeroporti hanno anche cercato una migliore condivisione delle informazioni tra le parti quali il controllo del traffico aereo, le linee aeree, l’attività aeroportuale e le operazioni a terra allo scopo di ridurre le emissioni indirette (Scope 3) tramite operazioni più efficienti dei trasporti in volo e a terra.
Aeroporti: Prossimi passi
Per ridurre le emissioni dirette, gli aeroporti stanno cercando di:
- Procurare energia rinnovabile, tramite accordi per gli acquisti o tramite installazioni per l’energia solare sul sito. Il consumo di elettricità può spesso rappresentare il 70% delle emissioni dirette degli aeroporti.
- Decarbonizzare le flotte a terra con veicoli elettrici o a idrogeno.
- Migliorare l’efficienza dei progetti di costruzione e sistemi HVAC. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere una fonte notevole di utilizzo dell’energia in climi più caldi e più freddi.
Per abbassare le emissioni indirette, quali i decolli delle linee aeree (nel raggio di un chilometro dall’aeroporto) e gli atterraggi nonché i trasporti a terra, che possono rappresentare dieci volte le emissioni dirette di un aeroporto, gli aeroporti stanno cercando di:
- Adottare e migliorare l’Airport Collaborative Decision Making (A-CDM). Ad esempio, condividendo aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni, gli aeroporti possono ridurre che i motori dei velivoli girino anche quando non è necessario.
- Installare basi di elettricità a terra e raffreddamento per limitare i tempi in cui girano i motori dei velivoli.
- Sostenere la decarbonizzazione di flotte per operazioni a terra.
- Sostenere la disponibilità di biocarburanti da utilizzare per le linee aeree.
Aeroporti: sfide e rischi
Gli aeroporti dovrebbero raggiungere i loro obiettivi di emissioni Scope 1 e 2 a mano a mano che aumenta la consapevolezza del loro ruolo come fonti di emissioni. Disponendo abitualmente di notevoli superfici, possono acquistare o investire in energia rinnovabile.
Le riduzioni Scope 1 sono notevolmente più difficili, dato che richiedono uno sviluppo della tecnologia degli aeromobili per realizzare tagli delle emissioni. Gli aeroporti hanno anche un ruolo notevole nel ridurre le emissioni con i trasporti via terra associati ai viaggi aerei. Mentre in molti casi ciò sarà dettato dalla decarbonizzazione del trasporto su strada, in altri casi gli aeroporti possono influire sugli spostamenti e incoraggiare trasporti via terra con emissioni minori entro i loro distretti.
Riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 dell’aeroporto di Sidney
L’aeroporto di Sydney ha un approccio fortemente integrato alla sostenibilità. Nel 2020 ha emesso la prima obbligazione della storia legata alla sostenibilità collocata nel mercato privato statunitense.
Gli aeroporti hanno una serie di stakeholder complessa; nel caso dell’aeroporto di Sidney, il governo federale (affitto, licenza operativa, biosicurezza, controllo di frontiera), il governo statale (trasporti a terra, servizi di emergenza), il governo locale (comunità e aziende locali, gestione dei rifiuti, rumorosità, strade) e linee aeree (clienti chiave), tanto per citarne qualcuno.
Tra gli obiettivi principali dell’aeroporto di Sidney per le emissioni dirette, vi sono la neutralità di carbonio entro il 2025 e una riduzione delle emissioni di carbonio per passeggero del 50% entro il 2025 (vs. valori di base del 2010). Per realizzarli, sta cercando tra l’altro di accedere ad energie rinnovabili, elettrificare la flotta di bus nel landside e realizzare un rating minimo 4 stelle di Green Star Design e As Built per nuovi sviluppi.
L’aeroporto sta anche sostenendo gli stakeholder nelle riduzioni di emissioni con vari mezzi:
- Miglioramento dell’efficienza dell’aerospazio e dei campi d’aviazione tramite A-CDM e installazioni di energia elettrica a terra e circolazione di aria precondizionata nelle aree di parcheggio degli aerei per ridurre i tempi di funzionamento dei motori aerei.
- Facilitazione dell’aumento fino al 50% dell’uso di vetture elettriche nell’airside.
- Miglioramento dell’efficienza e delle emissioni nel landside.
- Acquisizione di infrastrutture per carburanti che consentano migliori connessioni per i rifornimenti diretti e forniture di biocarburanti.
- Ricerca su altri aumenti di efficienza tramite iniziative quali la co-locazione di certe attività domestiche e internazionali, e ribilanciamenti delle piste.
Svariate strade per arrivare allo zero netto
Il passaggio allo zero netto è difficile, ma vi sono svariate strade da seguire per le infrastrutture. Ciascuna di queste richiederà investimenti di rilievo. Storicamente, le società di infrastrutture e i proprietari hanno ridotto gradualmente le emissioni di carbonio dei loro asset, e la tendenza è destinata ad accelerare con la crescita del supporto politico globale e delle pressioni sociali, oltre che con il calo dei costi delle attrezzature. Le infrastrutture quotate nelle borse globali consentono agli investitori di accedere a un investimento in via di accelerazione tramite asset liquidi di ottima qualità e diversificati geograficamente.
- L’elettrificazione della rete ferroviaria per il trasporto merci è una possibilità di lungo termine, che consentirebbe notevoli risparmi sull’efficienza dei combustibili. Al momento attuale, né le ferrovie né le autorità di regolamentazione desiderano perseguire quest’opzione, considerando i costi irrealistici associati all’elettrificazione della loro rete e dei locomotori. Tuttavia, con l’evoluzione nel tempo della tecnologia l’elettrificazione potrebbe diventare una possibilità.
Definizioni
L’Accordo di Parigi è un trattato internazionale legalmente vincolante sul cambiamento climatico, adottato in occasione della conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015.
L’Airport Collaborative Decision-Making (A-CDM) persegue un miglioramento dell’efficienza e della resilienza dell’attività aeroportuale ottimizzando l’uso di risorse e aumentando la prevedibilità del traffico aereo.
QUALI SONO I RISCHI?
Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Va ricordato che non è possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti degli indici non gestiti non riflettono alcuna commissione, spesa od onere di vendita.
I titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni dei prezzi e possibile perdita del capitale. I titoli obbligazionari comportano rischi legati a tassi d’interesse, di credito, di inflazione e rischi di reinvestimento, oltre alla possibile perdita del capitale. Quando i tassi d’interesse salgono, il valore dei titoli obbligazionari scende. Gli investimenti internazionali comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, incertezze sociali ed economiche e incertezze politiche che possono far aumentare la volatilità. Tali rischi sono amplificati nei mercati emergenti. Le materie prime e le valute sono più rischiose, comportando rischi che includono le condizioni di mercato, politiche, regolamentari e naturali, e possono non essere idonee per tutti gli investitori.
Treasury USA (UST) sono obbligazioni di debito dirette emesse e garantite dalla piena fiducia e dal credito del governo degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti garantisce il capitale e i pagamenti di interessi sui Treasury USA quando i titoli sono detenuti fino alla scadenza. A differenza dei Treasury USA, i titoli di debito emessi dalle agenzie federali e da enti paragovernativi e gli investimenti associati possono essere garantiti, ma non obbligatoriamente, dalla piena fiducia e dal credito del governo degli Stati Uniti. Anche quando il governo degli Stati Uniti garantisce il capitale e i pagamenti di interessi sui titoli, tale garanzia non si applica a perdite risultanti da cali del loro valore di mercato.
I gestori di investimenti a impatto e/o basati su fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possono selezionare i titoli considerando fattori al di fuori delle tradizionali informazioni finanziarie, con conseguente possibile scostamento delle performance relative degli investimenti rispetto a quelle di altre strategie o dei parametri di riferimento generali di mercato, laddove tali settori o investimenti risultassero favoriti o penalizzati dal mercato. Inoltre, le strategie ESG possono fondarsi su alcuni criteri basati sui valori per eliminare le esposizioni rilevate in strategie simili o in parametri di riferimento generali di mercato, anche in questo caso con conseguente possibile scostamento delle performance relative degli investimenti.