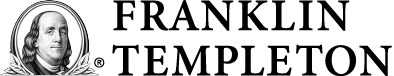CONTRIBUTORI

Sonal Desai, Ph.D.
Chief Investment Officer, Franklin Templeton Fixed Income
Abbiamo raggiunto un momento cruciale nelle guerre commerciali, con gli Stati Uniti che hanno stretto accordi preliminari con il Giappone e l'Unione Europea (UE). In entrambi i casi, gli Stati Uniti imporranno un dazio di base del 15%, anche se ci saranno esenzioni e possibili aliquote diverse per prodotti specifici.
L’UE è il principale partner commerciale degli Stati Uniti, rappresentando quasi un quinto delle importazioni statunitensi; il Giappone è il quinto, con il 5% delle importazioni. Questi accordi seguono quelli conclusi con il Regno Unito (2%), il Vietnam (4%), l’Indonesia (1%) e le Filippine (0,4%). I grandi assenti sono la Cina, il Canada e il Messico, che insieme rappresentano il 42% delle importazioni statunitensi. Tuttavia, mentre due settimane fa i progressi potevano sembrare trascurabili, ora l'obiettivo dell'amministrazione statunitense di rinegoziare le relazioni commerciali con i suoi partner sembra aver raggiunto un livello molto più avanzato..
È quindi il momento giusto per fare il punto della situazione:
a mio avviso, l’aspetto più sottovalutato è che i ricavi aggiuntivi derivanti dai dazi potrebbero essere consistenti. Come ho osservato tre mesi fa (On My Mind: T-Day), i dazi sono una tassa e, in questa fase, siamo in una posizione migliore per stimarne il probabile impatto sulle finanze pubbliche e sull'attività economica. Finora, nel corso di quest'anno, i dazi hanno reso circa 130 miliardi di dollari, rispetto a poco più di 50 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. 1
Proventi lordi generati dai dazi ~US$130 miliardi nei primi sette mesi del 2025
2018–2025

Fonti: US Treasury, Macrobond. Analisi a cura di Franklin Templeton Fixed Income Research. Al 4 agosto 2025.
Quale potrebbe essere un nuovo stato di equilibrio? I negoziati sono ancora in corso, ma, per avere un’idea, ipotizziamo che si arrivi all’equivalente di un dazio del 15% su tutti i prodotti, in linea con i recenti accordi tra UE e Giappone. Nel 2024 le importazioni ammontavano a 3.300 miliardi di dollari; supponiamo che rimangano invariate. Ipotizziamo inoltre che 1.000 miliardi di dollari di importazioni non siano soggetti a dazi, in quanto rientranti nell’accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada o grazie a esenzioni ad hoc. Un’aliquota del 15% sulle restanti importazioni pari a 2.300 miliardi di dollari genererebbe un gettito di circa 340 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con gli ultimi dati di entrata fiscale.
Si tratta di 260 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi tre anni: un incremento delle imposte pari a quasi l’1% del prodotto interno lordo (PIL). Ciò contribuirebbe a ridurre il disavanzo di bilancio nei prossimi anni a un livello compreso tra il 5% e il 6% del PIL, rispetto alle attuali proiezioni del 6-7% del PIL.2
In dieci anni, i ricavi aggiuntivi ammonterebbero a circa 2.600 miliardi di dollari, sostanzialmente pari all'aumento accumulato di 2.400 miliardi di dollari del disavanzo primario causato dal Big Beautiful Bill (BBB), secondo le stime del Congressional Budget Office (CBO).3
Ora la questione inizia a farsi interessante: secondo il CBO, prorogando i tagli fiscali previsti dal Tax Cuts and Jobs Act del 2017, il BBB ha “rinunciato” a 3.700 miliardi dollari di ricavi potenziali. Ciò è stato in parte compensato da tagli alla spesa pari a 1.300 miliardi dollari. Sembra che il resto potrebbe essere recuperato con un aumento delle imposte indirette, poiché i dazi all’importazione rappresentano di fatto un’imposta sulle vendite. La politica fiscale rimane accomodante, anche se in misura leggermente inferiore. Rispetto alle politiche esistenti, si registra un aumento delle imposte, che tuttavia riguarda le imposte indirette (sulle vendite di beni importati) e non tanto le imposte dirette (sul reddito delle famiglie e delle imprese).
Quale sarebbe l’entità di un tale aumento delle imposte? Il gettito totale dei dazi sarebbe equivalente a un’imposta sulle vendite del 5% su tutti i beni (nel 2024 il consumo di beni è stato di circa 6.200 miliardi di dollari su un totale di quasi 20.000 miliardi di beni e servizi). Significativo, ma non clamoroso: la maggior parte dei paesi dell'UE applica un’imposta sul valore aggiunto (IVA) di circa il 20-22% sulla maggior parte dei beni e servizi.
Gli economisti concordano sul fatto che le imposte indirette siano generalmente migliori rispetto alle imposte dirette: colpiscono una base più ampia, sono più facili da amministrare e riscuotere e non alterano gli incentivi al lavoro. (Sono, tuttavia, regressive, poiché le famiglie con redditi più bassi spendono una quota maggiore delle loro entrate e sono quindi colpite in modo relativamente più pesante).
I dazi sono un’imposta sulle vendite che opera una discriminazione a favore dei prodotti nazionali. Ma, all'interno di ogni paese europeo, anche l'IVA discrimina a favore di determinati beni e servizi (ad esempio prodotti alimentari, medicinali, libri), che sono soggetti ad aliquote inferiori o pari a zero.
Stiamo assistendo a un passaggio furtivo verso la tassazione indiretta, che sta passando inosservato per due motivi: il primo è che, poiché il CBO ha ignorato l’impatto dell’aumento dei dazi, questi non sono stati inseriti nel dibattito sul bilancio. Il secondo è l'argomentazione ambigua dell'amministrazione secondo cui i dazi saranno pagati dai produttori stranieri.
Con ogni probabilità, almeno tre quarti dell'onere dei dazi ricadrà sulle imprese e sulle famiglie statunitensi. In alcuni casi, i produttori stranieri potrebbero ridurre i prezzi per mantenere la quota di mercato, come hanno fatto le case automobilistiche giapponesi negli ultimi mesi, ma tali casi di ‘tassazione senza rappresentazione’ saranno molto probabilmente rari e forse temporanei. Finora le imprese statunitensi hanno assorbito la maggior parte dell'aumento delle imposte comprimendo i margini di profitto. Con la conclusione degli accordi commerciali, mi aspetto che una quota maggiore si ripercuoterà sui prezzi al consumo. Ciò comporterebbe un aumento moderato e temporaneo dell’inflazione e dovrebbe rallentare leggermente la crescita del PIL: stiamo già vedendo alcuni segnali in tal senso nei dati relativi all’attività economica e alla creazione di posti di lavoro. Tuttavia, se si volesse ridurre al minimo l'impatto di un’imposta indiretta sulla crescita, un dazio sulle importazioni sarebbe proprio la scelta giusta: la riduzione della domanda ricadrebbe in modo sproporzionato sulle importazioni, che non contribuiscono direttamente alla crescita del PIL.
Quali sono le principali implicazioni per queste prospettive economiche?
- Prevediamo un modesto rischio di downside per la crescita, anche se l'impatto dovrebbe essere moderato e, con un deficit di bilancio pari al 5-6% del PIL, la politica fiscale continuerà a essere espansiva. Ulteriori difficoltà potrebbero derivare dalle turbolenze sul fronte commerciale legate all’adeguamento delle catene di fornitura.
- Il compito della Federal Reserve (Fed) si complica. Le consistenti revisioni al ribasso dei recenti dati sull’occupazione confermano un certo indebolimento del mercato del lavoro, anche se il tasso di disoccupazione rimane esattamente allo stesso basso livello di un anno fa. Con i dazi che nei prossimi mesi potrebbero ripercuotersi maggiormente sui prezzi, la Fed dovrà valutare attentamente i rischi nello stabilire se e quando tagliare i tassi. Rimango dell'opinione che il margine per un taglio dei tassi sia estremamente limitato, a meno di un forte rallentamento, poiché siamo molto vicini alla mia stima del tasso neutrale di policy.
- La sfida fiscale a lungo termine rimane. In assenza di un miracolo in termini di produttività, essa dovrà essere affrontata attraverso una combinazione di tagli alla spesa e aumenti delle imposte. Sarà interessante vedere se questi aumenti significativi dei dazi si riveleranno in un primo passo verso un maggiore ricorso alle imposte indirette, come il percorso intrapreso da molte altre economie avanzate.
Note finali
- Fonte: How much are US tariffs raising in revenue? Bipartisan Policy. 23 aprile 2025.
- Non vi è alcuna garanzia che un’eventuale stima, proiezione o previsione si realizzi.
- Fonte: H.R. 1, One Big Beautiful Bill Act. Congressional Budget Office. 17 giugno 2025.
QUALI SONO I RISCHI?
Tutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.
I titoli obbligazionari comportano rischi legati a tassi d’interesse, di credito, di inflazione e rischi di reinvestimento, oltre alla possibile perdita del capitale. Quando i tassi d’interesse salgono, il valore dei titoli obbligazionari scende.
I titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni dei prezzi e a possibili perdite del capitale investito.
Non vi è alcuna garanzia che un’eventuale stima, proiezione o previsione si realizzi.