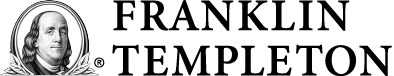CONTRIBUTORI

Kim Catechis
Investment Strategist,
Franklin Templeton Institute

Karolina Kosinska, CIPM
Analyst
Franklin Templeton Institute
Anteprima
Dal 2022, l’Europa ha ridotto la propria dipendenza dal gasdotto russo con una velocità sorprendente. Con lo stoccaggio di energia all’orizzonte, si profila un’enorme opportunità per l’Europa di focalizzare i propri sforzi sulla fornitura di energia pulita a basso costo, al fine di assicurare la competitività del settore manifatturiero e una transizione giusta. Contrariamente alla percezione diffusa, le energie rinnovabili rimangono la forma di elettricità più economica nella maggior parte dei mercati globali. Una rete elettrica di alta qualità, bassi tassi di interesse e il più grande mercato di consumo al mondo offrono all’Europa un’opportunità unica in un panorama geopolitico frammentato.”
In generale, prevale l’idea che i mercati finanziari europei non siano attraenti a causa di problemi strutturali che i governi non sembrano in grado di affrontare. Il presente documento indica che esiste una combinazione di necessità, opportunità e urgenza che potrebbe garantire prezzi dell’elettricità sostenibilmente bassi nel medio termine, con un impatto potenzialmente rivoluzionario.
Punti salienti:
- Si sta delineando un nuovo ordine economico e geopolitico, nel quale spiccano tre centri di gravità economica: Stati Uniti, Cina e Unione europea. Ognuno di essi presenta punti di forza e di debolezza strutturali, nonché sistemi di governance distinti che determinano in ultima analisi le scelte politiche. In questo contesto, la logica geoeconomica prevale sulla logica economica tradizionale.
- In questo mondo sempre più guidato dalla geopolitica, il ruolo della sicurezza energetica è centrale. Cina ed Europa, in particolare, affrontano una significativa vulnerabilità in questo ambito, che entrambe mirano a risolvere tramite l’elettrificazione. Le proiezioni indicano che la domanda globale di elettricità supererà il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL), almeno fino al 2030.
- Questo scenario impone una riorganizzazione della geografia economica, nella quale la disponibilità e il costo dell’energia diventano fattori critici. In generale, l’elettrificazione non è solo una sfida tecnologica, bensì anche un elemento strettamente correlato alle priorità politiche, allo sviluppo economico e alla sicurezza industriale e nazionale.
- In Europa, i tre principali motori dell’elettrificazione sono il cambiamento climatico, la digitalizzazione e le pressioni geopolitiche, che ne accelerano l’attuazione. Fortunatamente, l’Europa è all’avanguardia nella transizione verso le energie rinnovabili e già ricava il 48%1 della sua elettricità da fonti rinnovabili, rafforzando così la propria sicurezza energetica strategica.
- Si prospetta un’opportunità tangibile per l’Europa di costruire una rete elettrica continentale resiliente e strutturalmente a basso costo, che potrebbe dare un impulso significativo alla produttività, risollevando la regione dalla crisi economica.
- L’orizzonte temporale è il 2030 e gli indicatori da monitorare includono le politiche interne, la realizzazione dei progetti, le nuove interconnessioni e le infrastrutture di stoccaggio. Qualsiasi slittamento nei prossimi tre anni potrebbe determinare un considerevole slittamento dell’obiettivo prefissato.
- Attualmente, i paesi più avvantaggiati sono i Paesi Bassi, la Danimarca, il Regno Unito, la Spagna e la Germania, perché hanno compiuto i maggiori progressi nel settore delle energie rinnovabili e che hanno già abbattuto o sono in procinto di abbattere (entro 3-5 anni) il costo dell’elettricità. L’Italia è il paese che affronta le maggiori difficoltà (con una dipendenza dal gas del 56% e una produzione di eolica e solare ferma al 20%2). La Polonia (che si trova ad affrontare un potenziale deficit energetico a causa della chiusura di vecchie centrali e che dipende ancora per il 61% dal carbone, nonostante la crescita delle rinnovabili al 27%3) e la Francia potrebbero emergere come leader o rimanere indietro, in base alle decisioni politiche nazionali. Alcuni paesi, come la Svezia,4 operano in diversi mercati regionali, e la Germania potrebbe considerare la creazione di due zone, al fine di stimolare gli investimenti negli interconnettori.
- In definitiva, il mercato dell’energia all’ingrosso dell’Unione Europea (UE) opererà su tre pilastri:
- Un approvvigionamento con tariffe definite in base ad asset energetici puliti e a ridotti costi di esercizio (quali rinnovabili e nucleare) che richiedono investimenti in interconnettori per agevolare il trasferimento dell’energia in surplus verso le aree deficitarie.
- Un approvvigionamento supplementare con prezzi basati su contratti a lungo termine (quali gas trasportato via condotte, gas liquefatto trasportato via nave con consegne/prezzi fissi e regolari).
- Fabbisogno a breve termine con prezzi stabiliti sul mercato spot europeo (acquisti spot di elettricità o carichi di gas naturale liquefatto [GNL]).
- Il fondamento della fiducia in questo scenario è chiaro poiché l’elemento propulsore sia per la difesa che per l’elettricità coincide: la sopravvivenza in un mondo sempre più hobbesiano,5 dove i paesi devono imporsi o essere schiacciati.
Note finali
- Fonte: European Electricity Review 2025. EMBER. 23 gennaio 2025.
- Fonte: Countries and Regions: Italy. EMBER. Aggiornato al 9 ottobre 2024.
- Fonte: Changing course: Poland’s energy in 2023. EMBER. 7 febbraio 2024.
- Fonte: Svenska Kraftnät. Operazioni e mercati dell’energia elettrica: “La Svezia è suddivisa in quattro zone di offerta, dalla zona SE1 nel nord alla zona di Malmö SE4 nel sud. Il prezzo dell’elettricità in ciascuna zona di offerta è determinato dall’equilibrio tra domanda e offerta di elettricità e dalla capacità di trasmissione tra le zone.”
- Thomas Hobbes, filosofo inglese autore del celebre Leviatano (1651), sosteneva che lo Stato di Natura fosse uno stato di guerra, un mondo di conflitti per il potere e le scarse risorse, in cui i deboli sono destinati a una vita “solitaria, povera, brutale, bestiale e breve”.
QUALI SONO I RISCHI
Tutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.
I titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni dei prezzi e a possibili perdite del capitale investito.
Gli investimenti internazionali sono soggetti a rischi particolari, tra cui fluttuazioni valutarie e incertezze sociali, economiche e politiche, che potrebbero aumentare la volatilità. Nei mercati emergenti tali rischi risultano amplificati. Gli investimenti in aziende in un paese o regione specifici possono avere una maggiore volatilità rispetto a quelli più ampiamente diversificati a livello geografico.
Gli investimenti in Cina sono soggetti a maggiori livelli di rischio normativo rispetto ad altri paesi in ragione dell’elevata partecipazione del governo nell’attività economica.
Rischi particolari sono legati agli investimenti in Cina, Hong Kong e Taiwan, tra cui la riduzione della liquidità, l’espropriazione, la tassazione confiscatoria, le tensioni commerciali internazionali, la nazionalizzazione, le normative sul controllo dei cambi e la rapida inflazione, tutti fattori che possono avere un impatto negativo sul fondo. Gli investimenti a Taiwan potrebbero essere influenzati negativamente dalle relazioni politiche ed economiche con la Cina.
Le imprese del settore delle infrastrutture possono essere soggette a numerosi fattori, tra cui un’elevata spesa per interessi, un alto grado di leva finanziaria, gli effetti dei rallentamenti economici, l’aumento della concorrenza e l’impatto derivante dalle politiche e dalle pratiche governative e normative.
Le strategie d’investimento ambientale, sociale e di governance (ESG) dei gestori potrebbero limitare le tipologie e il numero di investimenti disponibili e, di conseguenza, potrebbero non sfruttare opportunità favorevoli sul mercato o sottoperformare le strategie che non tengono conto di questi aspetti. Non vi è alcuna garanzia che le direttive ESG della strategia avranno successo o porteranno a performance migliori.